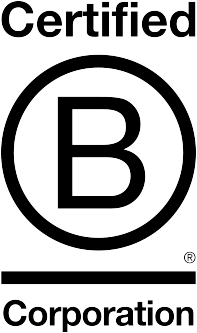Web reputation: come un tweet ti fa perdere il lavoro
Bastano pochi secondi. Il tempo di prendere lo smartphone prima di imbarcarsi per Città del Capo, twittare “Sto andando in Africa. Spero di non prendere l’Aids. Scherzo: sono bianca!”, trascorrere undici ore in volo e rendersi conto, non appena riacceso il telefono, che la carriera – soprattutto quella di un’esperta di pubbliche relazioni – è ormai compromessa. È quanto capitato a Justine Sacco, che ha sperimentato sulle proprie ossa la capacità del web di rovinare una vita, anche se non si tratta di una celebrità pubblica.
E il punto è proprio questo. L’idea che solo i personaggi famosi siano tenuti a controllare minuziosamente le informazioni che li riguardano che circolano in Rete rappresenta l’errore principale per chi, oggi, vuole far parte del mondo del lavoro o più semplicemente vuole essere parte attiva nella società. Il concetto è noto come “web reputation” e indica il complesso di informazioni a proposito di un soggetto che si possono facilmente reperire su Internet attraverso notizie, articoli di ogni tipo e profili social. Se fino a vent’anni fa il potere di influenzare la reputazione di una persona era prerogativa della carta stampata, oggi le possibilità si sono moltiplicate perché tre miliardi di utenti hanno accesso ad Internet e ognuno di loro può pubblicare un contenuto che, potenzialmente, potrebbe avere diffusione globale.
Per le persone fisiche, lo abbiamo visto, è un problema che riguarda essenzialmente la ricerca (o il mantenimento, visti i casi di licenziamento successivi ad un tweet di troppo) di un posto di lavoro. C’è chi, efficacemente, definisce la web reputation come il “poligrafo del curriculum vitae”, ossia come lo strumento che permette di verificare se quanto scriviamo nel nostro cv corrisponde al vero. E non è un segreto che sempre più aziende, prima di prendere una decisione su una nuova assunzione, sfruttino social media e motori di ricerca per ottenere un quadro completo del profilo che stanno selezionando.
Tuttavia si tratta di un’arma a doppio taglio, perché le stesse aziende che sfruttano la Rete per individuare i candidati migliori si trovano ad essere loro stesse studiate e influenzate da quella platea molto più folta che è rappresentata dai clienti, attuali o potenziali. Guardando ai casi concreti, si va dalle semplici recensioni online di hotel o ristoranti – sempre sfogliate con attenzione prima di una prenotazione – a casi di peso sociale ben maggiore, si pensi alla campagna social promossa da Barilla che ha portato l’azienda ad essere etichettata come omofoba, con conseguente necessità di correggere il tiro.
Solo un dato sembra essere certo: è necessario essere proattivi e plasmare la propria reputazione online, investendo tempo e (forse) denaro nella creazione di un profilo forte, in grado di dare ai terzi un’immagine solida e inattaccabile. La scelta di non presenziare in Rete, variamente motivata, porta con sé la duplice conseguenza negativa di non essere rintracciabili – dando, dunque, l’impressione di una scarsa attenzione alla gestione della propria immagine privata e professionale – e di non avere la forza di reagire ad un eventuale infangamento della propria reputazione, perché i tempi per consolidare la propria presenza sul web sono tutt’altro che rapidi, a differenza di quelli necessari per affossarla.
Proprio questa valutazione, unita al fiuto per una nuova e immensa opportunità di business, ha portato alla nascita dei c.d. professionisti della web reputation, soggetti privati o vere e proprie imprese strutturate che offrono ai clienti la possibilità di presentarsi in Rete con un profilo ai limiti dell’inattaccabilità. Ed è necessario precisare “ai limiti”, perché le informazioni che finiscono su Internet non possono essere cancellate in alcun modo: se c’è una macchia nella nostra reputazione digitale, potremo fare in modo di nasconderla o di renderla meno visibile, ma non ci sarà modo di eliminarla del tutto. In questo campo, la tecnica più utilizzata è nota come “flooding” e consiste in un intervento di forza bruta attraverso il quale la Rete viene inondata di contenuti positivi riguardo un soggetto al fine di coprire quantitativamente una certa notizia negativa: paradossalmente, è un’attività più semplice per un’azienda molto nota, e molto complessa per una persona fisica che difficilmente ha i mezzi per promuovere azioni positive da portare all’attenzione della platea virtuale (si pensi a Groupalia, portale leader nella vendita di coupon online che, a seguito di un infelice tweet nel quale proponeva ai cittadini colpiti dal terremoto dell’Emilia del 2012 di “mollare tutto e scappare a Santo Domingo”, in pochi minuti ha corretto il tiro dichiarando che avrebbe donato 1 euro alla Croce Rossa per ogni pacchetto venduto). Tuttavia, non mancano le critiche di chi sostiene che questi nuovi advisor della reputazione digitale consentono in buona sostanza di creare un’immagine fasulla, che può portare ad ingannare chi sta cercando di ricostruire il profilo di un soggetto, magari a fini lavorativi, con tutti i rischi che ne possono conseguire.
Va precisato che tecniche di questo tipo non sono utilizzate solo per coprire errori o gaffe commesse dal diretto interessato, ma anche e soprattutto per rimediare ai contenuti diffamatori pubblicati da altri utenti, quasi certi dell’impunità delle proprie azioni. Vi è invero la sensazione di una marcata inefficacia degli istituti giuridici tradizionali che, pur potendo condurre all’eliminazione del contenuto offensivo e alla condanna del soggetto diffamante, non hanno la forza di ricostituire la situazione antecedente all’attacco alla reputazione digitale poiché, si è detto, non è possibile eliminare completamente il contenuto che continuerà a circolare e ad essere reperibile. In questo contesto, il ruolo dei motori di ricerca si fa sempre più di rilievo, giacché rappresentano lo strumento che permette di fare uno screening della Rete e di trovare notizie – anche molto risalenti nel tempo – relative ad un certo soggetto. Influenzare l’ordine dei risultati su Google, tentando di relegare i contenuti negativi alle ultime pagine, sembra essere molto complesso a causa della matematicità dell’algoritmo utilizzato, e anche il diritto all’oblio ha un’efficacia solo parziale in quanto, se è vero che impedisce ad una notizia di apparire tra i risultati della ricerca, non impedisce in alcun modo di raggiungere la stessa notizia tramite un link diretto.
Guardando il fenomeno con gli occhi dei giganti del web – si pensi a siti host quali Tripadvisor, Facebook o Youtube – ciò che conta non è tanto la tutela della reputazione degli utenti, quanto la tutela della propria immagine e della propria posizione giuridica. Da un lato non vogliono finire nel vortice del public shaming ed essere etichettati come piattaforme che consentono supinamente offese e diffamazioni, dall’altro – e soprattutto – non vogliono essere chiamati in causa per la mancata rimozione di contenuti negativi di vario genere, operazione praticamente impossibile da realizzare vista la quantità di dati, immagini e video da controllare (si pensi a Youtube, 60 ore di video caricate ogni minuto, e al numero di dipendenti che servirebbero per un controllo minuzioso dei contenuti, situazione che è stata affrontata nel celebre caso Vividown c/ Google e che ha portato all’assoluzione dell’host). Conseguentemente, le grandi piattaforme si forniscono di policy più o meno rigide che permettono agli utenti di segnalare il contenuto offensivo o diffamatorio promettendone, a certe condizioni, la rimozione.
Proprio a tutela della propria web reputation, Facebook ha recentemente deciso di intervenire sulle condizioni di utilizzo del sito, vietando la vendita di armi da fuoco tra privati che in alcuni Stati degli Usa era pienamente legittima. A seguito di istanze, petizioni, attacchi pubblici che rischiavano di minare la credibilità della piattaforma – soprattutto in un momento storico in cui gli attacchi con armi da fuoco sono tutt’altro che infrequenti – la società di Mark Zuckerberg ha scelto di mostrarsi come “azienda morale” che partecipa attivamente a questioni di rilevanza sociale sulle quali la Casa Bianca, a prescindere dal colore dell’Amministrazione, ancora non è riuscita ad affrontare in maniera sistematica.
La necessità di creare un ambiente digitale sicuro e credibile rappresenta una banale conclusione dalla quale, però, non si può sfuggire. La conseguente necessità di creare istituti giuridici ad hoc non è, invece, una conclusione condivisa da tutti gli esperti che si dividono tra chi ritiene che sia sufficiente adattare e applicare le norme già esistenti, e chi sostiene che il diritto debba evolversi insieme alla tecnologia al fine, precisiamolo, non di ostacolarla o di imbavagliarla, ma di assecondarla e renderla sempre più efficace.